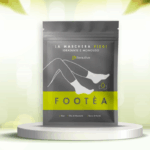Mangiare in modo sano è spesso considerato sinonimo di attenzione per il benessere fisico e mentale, e negli ultimi anni l’interesse per la qualità degli alimenti è cresciuto in modo esponenziale. Tuttavia, esiste una soglia sottile oltre cui la ricerca della purezza alimentare può divenire patologica e trasformarsi in una vera e propria malattia mentale: l’ortoressia nervosa. Questo disturbo, ancora troppo poco conosciuto, rappresenta una forma pericolosa di ossessione per l’alimentazione salutare e può avere conseguenze severe sia a livello fisico che psicologico.
Cos’è l’ortoressia e come nasce
L’ortoressia è definita come un disturbo alimentare caratterizzato da un’attenzione eccessiva e compulsiva per la qualità e la “purezza” degli alimenti, fino a creare rigide regole autoimposte che limitano drasticamente ciò che una persona si permette di mangiare. Questa ossessione si manifesta spesso con la minuziosa selezione degli ingredienti, il controllo quasi maniacale sull’origine e le tecniche di produzione, e una netta esclusione di tutto ciò che è ritenuto “non sano” o “impuro”, come cibi industriali, con additivi o semplicemente lavorati secondo metodi considerati non naturali. Con il tempo, le scelte alimentari si fanno sempre più restrittive, rischiando di compromettere l’equilibrio nutrizionale e la salute generale.
L’ortoressia nasce generalmente da motivazioni positive, come la volontà di tutelare il proprio corpo, prevenire malattie e seguire un ideale di vita salutare. Tuttavia, la costante esposizione a messaggi su diete detossificanti, “clean eating”, cibi bio e fitness ad ogni costo può portare alcune persone, soprattutto i più predisposti, a una visione estrema e distorta della nutrizione. La pressione sociale amplificata dai social media e la ricerca di controllo sulla propria vita sono ulteriori fattori di rischio.
I segnali di allarme: quando la ricerca del sano diventa malattia
Riconoscere l’ortoressia non è sempre semplice perché i suoi primi sintomi possono essere interpretati come attenzione salutistica. Tuttavia, esistono alcuni segnali ricorrenti che permettono di distinguere la prevenzione consapevole dal disturbo patologico:
- Ossessione per la qualità o purezza degli alimenti: costante preoccupazione per gli ingredienti, la loro provenienza, i metodi di coltivazione e produzione, fino a passare molto tempo a leggere etichette e a indagare su qualsiasi dettaglio della filiera.
- Eliminazione crescente di gruppi alimentari: esclusione completa di cibi ritenuti impuri, industriali, contenenti additivi, pesticidi, coloranti, zuccheri semplici, prodotti animali o qualsiasi alimento non conforme alle proprie regole, arrivando a mangiare solo pochi cibi “sicuri”.
- Pianificazione ossessiva dei pasti: preparazione esclusiva dei propri piatti secondo regole rigidissime, con difficoltà o rifiuto di consumare cibo preparato da altri o fuori casa, come nei ristoranti.
- Isolamento sociale: evitare eventi sociali in cui il controllo alimentare sarebbe messo in discussione, fino a ridurre drasticamente le interazioni sociali per non esporsi al rischio di trasgredire le proprie norme.
- Senso di colpa, ansia, disagio dopo “trasgressioni”: anche piccoli “sgarri” generano forte ansia, colpa o disgusto verso se stessi, alimentando un ciclo di auto-restrizione e controllo.
- Perdita di peso e carenze nutrizionali: la selezione sempre più ristretta degli alimenti comporta spesso (come accade nell’ortoressia) deficit vitaminici, minerali, energetici, con perdita di massa muscolare e problemi a carico di più organi e sistemi.
- Incremento eccessivo di esercizio fisico: in alcuni casi, l’attenzione per il “pulito” si estende all’attività sportiva, con sedute troppo intense che si aggiungono alla debolezza causata da una dieta povera.
L’impatto sulla vita quotidiana può essere profondo: la maggior parte del tempo e delle energie è dedicata alla preparazione dei pasti e al controllo delle regole autoimposte, a discapito delle relazioni personali e delle altre attività.
Le conseguenze fisiche e psicologiche dell’ortoressia
Un focus eccessivo sulla “purezza” alimentare non solo limita la varietà della dieta, ma può anche sfociare in malnutrizione, perdita di peso marcata, anemia, deficit di vitamine e minerali essenziali. Soprattutto nei giovani e nelle persone vulnerabili, le conseguenze possono arrivare fino a gravi danni cardiaci, compromissione del sistema immunitario e problemi gastrointestinali.
Dal punto di vista psicologico, l’ortoressia favorisce l’isolamento sociale, la perdita di interesse per le situazioni condivise, e una costante insoddisfazione verso se stessi, dominata da ansia, senso di fallimento e pensieri ossessivi. Spesso sono presenti anche sintomi depressivi e una bassa autostima, aggravati dal confronto permanente con modelli – reali o virtuali – considerati irraggiungibili.
Col tempo, questo stile di vita può trasformarsi in una trappola che soffoca la spontaneità, la gioia di stare insieme e la serenità emotiva, amplificando il disagio anziché favorire la salute.
Prevenzione, diagnosi e strategie di intervento
Prevenire l’ortoressia significa riconoscere precocemente i segnali d’allarme e intervenire tempestivamente. La conoscenza del problema è il primo passo: sia i familiari che i professionisti devono imparare a distinguere tra un’alimentazione sana ed equilibrata e un’ossessione che limita la libertà personale e mette a rischio la salute.
- Diagnosi precoce: fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in disturbi alimentari. Psicologi, medici e nutrizionisti possono intervenire per valutare la presenza dei sintomi e impostare trattamenti individualizzati.
- Psicoterapia: la terapia cognitivo-comportamentale (TCC) è tra gli approcci più efficaci. Aiuta a modificare i pensieri disfunzionali e i comportamenti ossessivi legati al cibo, favorendo una relazione più sana e meno rigida con l’alimentazione.
- Educazione alimentare equilibrata: rieducare il rapporto col cibo, favorendo la riscoperta del piacere di mangiare insieme agli altri e la capacità di adattarsi alle esigenze del corpo, piuttosto che a schemi rigidi e spesso infondati.
- Supporto familiare e sociale: il sostegno del contesto di vita è essenziale per incoraggiare piccoli passi verso la flessibilità e la riapertura alla convivialità.
- Quando necessario, terapia farmacologica: alcuni casi particolarmente gravi possono richiedere il supporto di farmaci per la gestione di ansia, ossessioni o sintomi depressivi correlati.
Un elemento cruciale è la consapevolezza: imparare a capire quando le regole alimentari diventano un ostacolo al benessere, piuttosto che un aiuto, richiede coraggio e fiducia. Accettare di non poter controllare ogni elemento della propria dieta è un importante segnale di recupero della libertà personale.
L’ortoressia, come altri disturbi alimentari, si combatte anche attraverso la lotta agli stereotipi e la promozione di un’informazione corretta. Evocare un rapporto sano e flessibile con la nutrizione, aperto alla varietà e al cambiamento, è un antidoto culturale contro la pericolosa illusione della perfezione alimentare.